SCHEDA DI APPROFONDIMENTO.
Chiavi e serramenti, quinta parte. Aspetti tecnici.
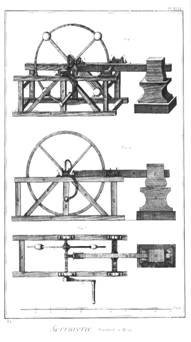
Dalla “Encyclopedie” di Diderot e D’Alembert. Maglio
meccanico a mano, di grandi dimensioni, destinato alla fucinatura delle lamiere.
Notiamo l’ampio volano, che permetteva una cadenza regolare dei colpi.
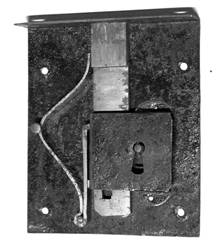
Serratura
sette-ottocentesca, da cassetto. Cm 12,4x10,6x2,2. Chiave femmina. Notiamo la raffinata
molla realizzata con un perno d’appoggio, che ne ottimizza il funzionamento
raddoppiandone la leva. La vernice nera con cui è ricoperta la scatola è tipica
di questo periodo e rivestiva carattere decorativo, accordandosi con i
particolari ebanizzati, spesso presenti sui mobili, in accordo con i moderni
dettami decorativi del Biedermeier; serviva inoltre quale antiruggine.


Serratura ottocentesca, da cassetto, cm 9,2x7,3x1,3, di fattura modesta. Chiave femmina. Uno scatto, un Ingegno. Notiamo il gancio di arresto del chiavistello ed i fori svasati per le viti di fissaggio.

Serratura
della prima metà dell’Ottocento. Notiamo anche in questo caso la vernice nera
con funzione protettiva, che è elegantemente incisa a disegno geometrico. La
piastra trapezoidale è tipica degli arredi Restaurazione (1815-30).
Nelle
aree periferiche la produzione delle serrature resta a lungo alquanto rustica.
L’evidente fabbricazione manuale non è indice di maggior valore del manufatto,
ma solo di una prolungata arretratezza di quelle botteghe, che non potendo
accedere sia per ragioni geografiche, sia per i costi più elevati, ai fornitori
di serrature più specializzati e sviluppati, dovevano accontentarsi della
produzione di fabbri locali. D'altronde anche la loro clientela era meno
aggiornata ed esigente e con minori possibilità economiche.
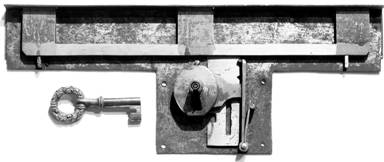
![]()


Raffinate
serrature di un secretair Consolato (1800-05), stampigliato Eckel, ebanista
parigino di origine tedesca. Quella della ribalta (davanti e retro), cm
11,7x31x1,5, presenta tre chiavistelli azionati da due scatti della chiave. La
parte a vista di tale serratura, che non viene coperta dalla pelle del piano
scrittoio, è rivestita da una lamiera di ottone rivettata alla scatola
d’acciaio. La serratura, cm 44x6x1,5, dello sportello inferiore, ha tutta la
scatola a vista di ottone ed è elegantemente sagomata. La leva, che alza la
molla è pure di ottone. Per entrambe unica chiave (cm 7,4) d’acciaio con
impugnatura di bronzo cesellato e dorato. Gli innesti sono a doppio cerchio.
Secretair proprietà dell’autore.
Nei
secretair di qualità il vano inferiore presenta due sportelli (in francese
secretair a vanteaux) essi celano un castello, che può essere a tre cassetti o
variamente suddiviso. Questo consente una migliore e più omogenea distribuzione
dei fogli di impiallacciatura senza che il disegno sia disturbato dalle
divisioni orizzontali tra i cassetti, come avviene, quando essi sono a vista.
La serratura della ribalta presenta sempre due un chiavistello a due o tre
innesti. Quella provvista di aste di chiusura con inserimento nei montanti
laterali è normalmente ancora settecentesca, oppure destinata alla ribalta di
un boureau; al fine di non disturbare il piano scrittoio con ingombranti
innesti, come avviene in quelli più rustici. La serratura con un solo
catenaccio è sinonimo di costruzione modesta, di aree periferiche, italiana o
mitteleuropea.
Nelle
serrature francesi neoclassiche è usuale rivestire la parte della serratura a
vista, inserita tra l’impellicciatura, con una lamiera di ottone o produrre
tutta la scatola, se interamente a vista, di ottone, anche le cerniere sono
spesso d’acciaio rivestite o tutte d’ottone.


Serratura
di acciaio da sportello I° Impero, cm h. 7x6x3. Gancio per detta, cm8x22x0,3, situato
a metà del piano divisorio interno. Appartenenti ad una credenza a due
sportelli. Proprietà dell’autore.
Quando
la serratura è collocata a metà dello sportello ed il suo gancio è situato in
corrispondenza, a metà di un piano divisorio interno, siamo sicuri che il
mobile non ha subito modifiche; se invece la serratura, come quella del
secretair precedente, percorre tutto lo sportello verticalmente innestandosi
nei montanti superiore ed inferiore, detto sportello poteva chiudere una
cassettiera, che ovviamente non avrebbe potuto ospitare un gancio a metà di un
cassetto, che di norma erano in numero di tre. Nel corso dell’Ottocento la
necessità di mobili credenze ha portato sovente a tale modifica con l’eliminazione
della cassettiera, che spesso nasceva già estraibile, e l’introduzione di un
piano divisorio.
In
Europa è con l’Ottocento e l’affermazione della borghesia e dei suoi usi, che
si formalizza la destinazione di ambienti specifici per il pranzo e di conseguenza
si rende necessaria, per le case meno lussuose e provviste di minor servitù, la
fabbricazione di mobili contenitori per il vasellame. Altrimenti l’occorrente è
portato in tavola da altri ambienti di servizio, che ovviamente non
necessitavano di arredi costosi, ma di più semplici scansie. Le credenze e le
sacrestie, come si desume dallo stesso vocabolo di evidente origine
ecclesiastica, erano collocate appunto nelle sacrestie per contenere gli
apparati destinati all’altare. Di sicuro i nobili di rango non facevano
prendere le stoviglie od imbandire le tavole davanti agli ospiti. Ciononostante
esistono rari arredi d’epoca a sportelli provenienti dai negozi, dalle
farmacie, ecc.
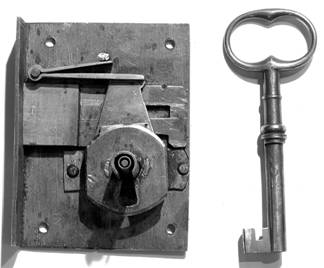
Serratura,
cm 9,3x7,2x2,1, e chiave, cm 10, di vetrina I° Impero. Francia. Innesto a
doppio cerchio, piastra di ottone. Notiamo la molla a V, con rivettata la sua
leva di ottone. Notiamo l’ampia e comoda impugnatura della chiave che fungeva
da maniglia per lo sportello. Vetrina proprietà dell’autore.

Serratura
da cassetto I° Impero. Innesto a quadrifoglio per chiave femmina egualmente
sagomata. Piastra superiore rivestita di lamiera di ottone rivettata alla
scatola. Due scatti, Piemonte-Savoia. Cm 6,7x13,3x1,7. Notiamo che la leva è
ricavata da una piegatura della molla, invece che dalla placchetta tipica dei
modelli francesi coevi. Anche l’arresto del catenaccio è realizzato da un
ingrossamento del suo terminale. Di norma una scanalatura praticata nel
chiavistello funge da guida e da arresto, come nelle serrature precedenti.
Quando
gli innesti e le corrispondenti chiavi sono sagomati ciò è sempre indice di
produzione da parte di officine specializzate e di ricerca di una maggiore
qualità estetica. Tale costruzione aveva fini puramente ornamentali, essendo
sempre possibile scassinare con grimaldelli piuttosto semplici anche queste
serrature.
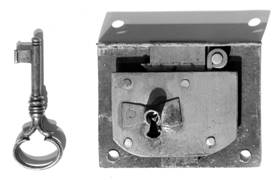

Elegante
chiave maschio, cm 6, e serratura, cm 5x6,5x1,4, del cassetto di un tavolino da
lavoro austriaco Biedermeier (1815-48). Nonostante una lavorazione già
industriale, notiamo l’elegante diamantatura a vista della scatola e la
rifinitura a lima. I fori sono svasati per l’impanatura delle viti. Tavolino
proprietà dell’autore.
Le
serrature ottocentesche di area mitteleuropea presentano spesso raffinatezze a
volte insospettabili, anche in quelle da incasso, che una volta montate non
erano visibili; al ferraiolo ciò non interessava lui le eseguiva comunque al
meglio. Le corporazioni sopravvissero a lungo in questi stati garantendo
standard qualitativi eccellenti, anche nelle produzioni non di lusso.


Serratura,
cm 18x3, e chiave femmina, 5x1,2, da sportello, seconda metà dell’Ottocento. Lavorazione
industriale con finitura manuale a lima.
Le aste smontabili, non illustrate, sono a mezzo tondo, come i suoi
cavallotti, che servono a tenerle in linea. Esse potevano essere montate di
lunghezza differente secondo l’altezza dello sportello. Notiamo i rivetti
trafilati perfettamente cilindrici. La chiave è stampata.


Serratura
industriale tra Otto e Novecento. Notiamo i rivetti montati a macchina su di una
lamiera di spessore assolutamente uniforme.
Nelle
serrature industriali la mappa e la chiave sono di misure ridotte, sia per
risparmiare sui costi di produzione, sia per renderne più agevole la
portabilità. Sono normalmente ad un solo scatto ed a volte la toppa è disposta
sia orizzontalmente, sia verticalmente per consentire di montare la serratura
sia in verticale su un cassetto, sia in orizzontale su uno sportello. Se la
chiave si introduce da un sol lato è sempre femmina, se, come in quelle da porta,
si introduce dai due lati è maschio. Dalla fine del secolo a volte è applicata
una serratura di tipo Yale.
Le serrature presentate sono proprietà dell’autore.
Un ringraziamento particolare al maestro ferraiolo Leonardo Dingi di Bologna, per i preziosi consigli.
Queste schede tecniche d’antiquariato sono
state scritte dall’antiquario Pierdario Santoro, con la collaborazione della
moglie Mara Bortolotto, per la rubrica mensile edita sulla rivista
“L’Informatore Europeo”. L’originale è corredato da foto e didascalie, qui non
riportate.