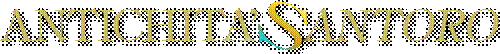
Bologna, via
Nazario Sauro 14/b
Tel. 051260619
3356635498 3358495248
Queste schede tecniche d’antiquariato sono
state scritte dall’antiquario Pierdario Santoro
per la rubrica mensile edita sulla rivista
“L’Informatore Europeo”. L’originale è corredato da foto e didascalie, qui non
riportate.
Si
ringrazia per la collaborazione la Professoressa Mara Bortolotto, perito d'Arte
presso il Tribunale di Bologna (www.peritoarte.it).
Scheda di approfondimento.
I
bastoni. Parte prima. La storia fino al Settecento.
Per bastoni s’intendono diverse tipologie di oggetti
aventi in comune la caratteristica di estendersi in lunghezza più che in
larghezza e di essere stati sempre e in ogni luogo presenti con tre funzioni
fondamentali: appoggio, difesa, apparato. Questa descrizione molto generica fa
comprendere immediatamente quanto sia vasta la tipologia dei bastoni. Il
bastone accompagna la storia dell’uomo. Esso è stato di volta in volta arnese,
arma, accessorio rituale o di abbigliamento. Come arma si passa dalla semplice
clava al sofisticato bastone armato; come arnese esso è stato appoggio del
viandante e strumento del pastore, ma anche gnomone per la determinazione
dell’ora solare; quale accessorio nell’abbigliamento a fini rituali, andando
dallo scettro al pastorale, e nella moda da quello del dandy a quello della
cocotte.
La civiltà egizia fu ricca di
bastoni sia corti sia lunghi, documentati in disegni e incisioni; uno degli
esempi più noti è quello della tomba di Tutankhamon, dove sono stati ritrovati
diversi bastoni; molti dei quali erano appartenuti ai vari dignitari quale
segno del loro ufficio, ed erano stati lì depositati in segno di omaggio. Tutti
conosciamo il racconto biblico, dove Mosè e i sacerdoti del faraone si
affrontano trasformando in serpenti i propri bastoni, che ci conferma il loro
uso anche a corte. È in Oriente in area assiro-babilonese che il bastone assurse
al rango di oggetto di lusso, non solo rituale o pratico. In linea di massima
il bastone lungo era attributo regale o divino, mentre quello corto era
riservato ai dignitari. Il pedum era
il classico bastone romano, oggetto d’uso, usato dai pastori per tenere a bada
il gregge, per difesa, per cacciare, per raccogliere la frutta meno
accessibile. Ad un gancio in cima al bastone si poteva appendere una fiasca,
una zucca per l’acqua o un fagotto col cibo, per agevolarne il trasporto a
spalla o, una volta piantato a terra, per proteggerli dalla polvere e dagli
insetti. Esso era anche simbolo di comando, dai fasci di verghe, che accompagnavano
i consoli, alla canna messa in mano al Cristo per dileggiarne la regalità. Nella
mitologia il bastone era attributo soprattutto delle divinità agresti come: i
centauri, Attenone, Silvano, Pan, Orione, Talia (quale musa della poesia
pastorale). C’erano anche bastoni più complessi come il caduceo di Mercurio,
raffigurato con avvinghiata una serpe (a significare il rinnovarsi della vita
esemplificato dal serpente che cambia pelle ogni anno) con cui egli curava i
mali dell’uomo, poi divenuto simbolo dei medici; o quello dell’indovino
Tiresia, detto tiresiade, ornato da una pigna come terminale. Non dimentichiamo
la clava, arma sempre efficace, di Ercole.
La liturgia cristiana colloca
il bastone in una posizione preminente, assumendolo a simbolo del Buon Pastore,
com’era spesso chiamato il Cristo, pastore di anime, soprattutto nelle prime
comunità cristiane. Il pedo è
l’attributo delle alte gerarchie cattoliche episcopali, un pastorale alto e dritto sormontato da un crocefisso per il Papa,
quale vescovo di Roma, con terminale a riccio per gli altri Vescovi. I Vescovi
greco-ortodossi lo portano con
un’asticella terminale variamente decorata. Il 4 ottobre 2001 la statua di San
Petronio, realizzata dallo scultore Gabriele Brunelli per l'Arte dei Drappieri
nel 1683, è stata ricollocata in piazza di Porta Ravegnana, davanti alle due
torri, da dove era stata rimossa alla fine dell’Ottocento per motivi di traffico. In un primo momento
la statua era priva del pastorale, poi, in seguito a numerose segnalazioni, una
copia in resina di quello originale, molto pesante e che già era rovinato pericolosamente
a terra in passato, è stata collocata quale necessario simbolo del Vescovo
patrono della città. Durante le Crociate e fino al Cinquecento il bordone o baculo fu segno distintivo del pellegrino, che si recava in Terra
Santa. Durante il medioevo il bastone tornò a essere simbolo di una carica;
tipici quelli corti degli araldi; anche le donne ne adottarono di lunghi,
spesso di canna, perché più leggeri, e ornati di nastri. Il bastone
evidentemente è anche un simbolo fallico, soprattutto quando dritto termina con
un pomolo; ecco perché probabilmente i nastri, oltre a soddisfare desideri di
decorazione delle dame, li differenziavano da tale similitudine. Nel
Rinascimento per le dame comparvero anche corti bastoni d’avorio, omaggio
spesso regale e segno di particolare distinzione a corte. I Monarchi sfoggiavano
bastoni lunghi dalla ricchissima decorazione d’oro, perle e gemme. Corti
bastoncini d’avorio torniti, con sulla cima simboli araldici, erano distintivi
dei potenti del Quattrocento. Nel Cinquecento diventarono di uso comune bastoni
di canna, malacca o legno di palma, non solo da donna, e quelli più robusti e
decorati da passeggio. Il pedometro
era un bastone munito di un cursore, che ogni volta che era battuto a terra si
spostava di una tacca contando i passi percorsi. Nascono anche i bastoni
armati. I più comuni erano cavi e muniti di un micidiale spadino triangolare,
quelli più complessi potevano essere corredati di uno stiletto e addirittura di
una pistola e di un martello da guerra, contenuti nell’impugnatura. I più
mirabili sono di costruzione tedesca. Sono sopravvissute impugnature d’avorio,
che si distinguono per essere scolpite con soggetti laici, normalmente
femminili, al contrario della scultura tradizionale, che era a soggetto
prevalentemente religioso. Nel Seicento si diffuse il bastone da passeggio, propagandato
dall’uso che ne fecero monarchi importanti come Luigi XIII e Luigi XIV. Quest’ultimo
incrementò l’uso del bastone con pomolo d’agata ma guai a sfoggiarlo senza
precisa autorizzazione in sua presenza; parimenti proibì l’uso di servirsi a
corte di bastoni cavi come cerbottane per inviarsi messaggi amorosi. Le dame
utilizzavano molto tali bastoni alti e dritti soprattutto per appoggiarvisi,
mantenendo l’equilibrio reso precario dalla moda dei tacchi molto alti su
strade normalmente mal tenute, ornandoli sempre di nastri e nappe nei colori
della propria casata; per lo stesso motivo le attrici erano obbligate a usare
il bastone, che oltre a favorirne l’equilibrio ne accentuava la gestualità. Si diffuse
l’uso di mazze pesanti e riccamente ornate simbolo della delega del potere
assoluto ai funzionari; d’esse sopravvive il ricordo nelle mazze che sono
esposte alle inaugurazioni degli anni giudiziari. Dalla metà del secolo si praticò
la tecnica del piquetè, consistente
nel conficcare nel pomolo d’avorio chiodini d’argento, eseguendo disegni più o
meno complessi. Grande successo ebbero i bastoni dotati di orologio,
generalmente inserito nel pomolo, e quelli solari con meridiane di varia
complessità. Un’altra tipologia, sempre di funzione pratica, serviva ad
allontanare. I servi dei signori utilizzavano un bastone pesante, munito di una
frusta estraibile con cui convincere anche i più recalcitranti a spostarsi al
passaggio dei loro padroni. Gli scaccini
erano invece gli aiuti dei sacrestani, incaricati di scacciare cani e
mendicanti durante le funzioni con l’aiuto di bastoni semplici o ornati secondo
dell’importanza della chiesa da proteggere.