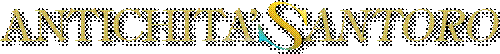
Bologna, via
Nazario Sauro 14/b
Tel. 051260619
3356635498 3358495248
Queste schede tecniche d’antiquariato sono
state scritte dall’antiquario Pierdario Santoro
per la rubrica mensile edita sulla rivista
“L’Informatore Europeo”. L’originale è corredato da foto e didascalie, qui non
riportate.
Si
ringrazia per la collaborazione la Professoressa Mara Bortolotto, perito d'Arte
presso il Tribunale di Bologna (www.peritoarte.it).
Scheda di approfondimento.
L’estampille,
cenni storici.
La traduzione più vicina a estampille
è marchio, sia nel senso attuale di nome identificativo della ditta che lo
utilizza, sia in quello tecnico di marchiato, impresso. Con esso non s’intende
l’apposizione di una firma personale ed esclusivamente identificativa
dell’artista, ma il nome della bottega o dell’impresa facente riferimento a
quel marchio. Siamo molto vicini a ciò che oggi si definisce una griffe.
In quest’accezione tale termine si applica a una molteplicità di tipologie,
dalle opere di scultura, nei vari materiali di esecuzione, a quelle
manifatturiere, ecc. In questa scheda prendiamo in esame le estampilles
presenti nella produzione francese degli arredi del XVIII e del XIX secolo; che
sono le più note e antiquarialmente interessanti.
È nel XIII sec. che comparve in
Francia la corporazione dei lavoratori del legno, detti della piccola scure
(petite cognée). Un secolo dopo, dal 1367 al 1382, ne furono codificate le
regole dal prevosto di Parigi, Hugues Aubriot. Per appartenere alla categoria
dei Maîtres
(Maestri) era necessario lavorare tre anni come apprendista, tre anni come compagnon
(collaboratore) di un maestro e sostenere un esame consistente nell’esecuzione
di un capo d’opera (un arredo importante) posto all’esame e
all’approvazione dei maestri e pagare una tassa, che variava a seconda delle
origini del candidato, dalle 120 lire per il figlio di un giurato alle 530 per
un lavoratore estraneo alla corporazione, inoltre dovevano essere cattolici e
francesi. Da notare che lo stipendio medio di un operaio specializzato era
inferiore alle 200 lire, appena sufficiente per vivere, comprendiamo quindi la
difficoltà di poter pagare tali cifre, oltre al costo rilevante del capo
d’opera. Nel 1467 si ottenne la divisione all’interno della corporazione tra la
categoria dei falegnami e quella dei tappezzieri. Nel corso del 600’ l’uso
dell’ebano, per il rivestimento dei mobili di lusso, portò alla definizione di ebanista
e alla successiva separazione all’interno della corporazione tra i falegnami,
cui spettava l’esecuzione dei mobili di legno massiccio o dei fusti, e gli
ebanisti, cui solo era consentita l’esecuzione dei mobili placcati. Nel 1637 il
Parlamento di Parigi decretò l’obbligo che: <ciascun maestro falegname sarà
tenuto a marcare con il suo marchio particolare tutte le opere… e marcare il
detto marchio in una tavoletta di piombo che sarà conservata presso la camera
del sostituto del nostro procuratore generale allo Chastellet>. Dal 400’ esistono estampilles impresse a
fuoco, a freddo o marcate a inchiostro, ma rappresentano un’assoluta eccezione.
È solo dal 1741 (lo statuto definitivo è del 1743) che fu ripristinato e
applicato l’obbligo di marchiare le opere prima di metterle in vendita, pena la
confisca e una multa di 20 lire (in Francia la moneta era la lira) per
ciascuna; chi contraffaceva un’estampille e chi avesse collaborato alla contraffazione,
era condannato a pagare 300 lire. I Maîtres parigini erano anche soggetti al
pagamento di un’imposta di dieci soldi ai giurati della corporazione per ogni
arredo, presente in bottega regolarmente stampigliato, che veniva marchiato con
il sigillo della jurande. Non erano soggetti all’obbligo di marchiatura
gli artigiani non parigini, salvo statuti locali come quelli vigenti in altre
grandi città, come Bordeaux, Lione, ecc., i lavoratori liberi e gli ebanisti
residenti nei luoghi privilegiati (con statuti risalenti al medioevo), come gli
enclos: de Saint-Jean-de-Latran, du Temple, de Saint-Denis-de-la-Chartre e,
soprattutto, dell’abazia di Saint-Antoine des-Champs che controllava il
faubourg Saint-Antoine, quartiere degli ébénistes. Vi erano poi anche gli
ebanisti dispensati per privilegio reale, istallati ai Gobelins, al Louvre o
all’Arsenale, i quattro ebanisti privilegiati del Re, ecc. I marchands-merciers
(mercanti-merciai) non erano soggetti ad alcun obbligo e potevano anche
acquistare gli arredi direttamente dagli operai liberi; a volte falsificavano
le estampilles per dare maggior credito alla loro merce. In fine i privati
potevano comprare direttamente dagli artigiani arredi non stampigliati, con il
solo obbligo di ritirarli personalmente presso l’atelier. I giurati della
corporazione risiedevano presso la comunità dei menuisiers-ébénistes in via
della Mortellerie e avevano l’obbligo di visitare i laboratori quattro volte
l’anno, confiscando gli arredi privi di marchio dell’ebanista o difettosi e
apponendo il loro: JME (JME, sta per Jurande
des Menuisiers Ebénistes, corpo degli ufficiali giurati dei
falegnami-ebanisti).
La
jurande era composta di sette persone: un principale
o sindaco, in carica un anno, scelto
tra i maestri anziani, e sei giurati eletti tre alla volta ogni anno, ma con
incarico biennale. La lotta in difesa della corporazione era costante e
innumerevoli erano gli appostamenti alle porte dei luoghi privilegiati per sorprendere
gli artigiani al momento della consegna e sequestrare la merce irregolare. I
maestri erano gli unici artigiani autorizzati a vendere direttamente le proprie
opere. Da una parte tale legislatura rendeva rigida la produzione a vantaggio
dei membri della corporazione, ma dall’altra essa garantì la tutela della
qualità, che segnò la supremazia dell’ebanisteria francese. Nel 1791 le
corporazioni furono abolite e con esse l’obbligo della stampigliatura. In
realtà per tutto il XIX secolo si continuò a stampigliare gli arredi, fino al
trionfo definitivo dell’odierna marca. In particolare durante il governo
napoleonico i mobili destinati al garde-meubles erano stampigliati al fine di
ricevere le sovvenzioni stabilite quale sostegno economico da Napoleone
direttamente per gli artigiani; per tale motivo molti arredi dei più importanti
ebanisti di questo periodo sono marchiati.