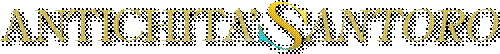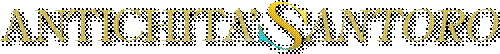
Bologna, via
Nazario Sauro 14/b
Tel. 051260619
3356635498 3358495248
Queste schede tecniche d’antiquariato sono
state scritte dall’antiquario Pierdario Santoro
per la rubrica mensile edita sulla rivista
“L’Informatore Europeo”. L’originale è corredato da foto e didascalie, qui non
riportate.
Si
ringrazia per la collaborazione la Professoressa Mara Bortolotto, perito d'Arte
presso il Tribunale di Bologna (www.peritoarte.it).
Scheda di approfondimento.
Il vetro. Prima parte.
Il vetro probabilmente è esistito da
sempre: si forma in modo naturale a seguito di fenomeni fisici che
portarono ad innalzamenti repentini della temperatura ed alla fusione di
sabbia, quarzo e rocce silicee. Il vetro si presenta duro e compatto, ma, al contrario
di altri materiali come ad esempio il ferro, è in grado di passare dallo stato
liquido a quello solido senza alcuna trasformazione strutturale. La
fluidità tipica del vetro, ogni volta che è riscaldato, è la sua caratteristica
saliente. Il vetro fonde totalmente tra i 1300 ed i 1500 gradi. Fino al
Rinascimento i forni non riuscivano a raggiungere temperature superiori ai 1100
gradi, appena sufficienti a realizzare la fritta,
quel insieme di minerali necessari a fabbricare i mattoni di vetro, con cui poi
si fabbricavano le opere. L’incompleta fusione comportava la presenza di
impurità e bollicine, che lo rendevano più o meno trasparente. È sempre
necessario raffreddare molto lentamente il manufatto, onde evitare la
cristallizzazione dei componenti silicei, che rende il vetro opaco e fragile. I
forni erano mantenuti costantemente accesi, per mantenere la temperatura così
faticosamente raggiunta. La sostituzione del calderone era un’operazione
drammatica. Penetrando per non più di due minuti da un foro praticato in una
parete, avvolti in panni bagnati, gli operai si alternavano nel forno
incandescente per sganciare, caricare il vecchio e collocare il nuovo. Il
combustibile era costituito dal legno e solo dal cinquecento si sviluppa in
Inghilterra, a causa della rarefazione dei boschi, il forno conico alimentato a
carbone. La lavorazione tipica del vetro è quella realizzata a caldo. Le
ulteriori lavorazioni eseguite a freddo, come il taglio alla mola o l’incisione
a diamante, sono comuni anche ad altri materiali.
Si pensa che già l'uomo all'età della
pietra utilizzasse questo tipo di prodotto naturale per costruire strumenti
affilati. La tradizione, come riportato da Plinio, vuole che a scoprire il
vetro e a prendere coscienza di questo materiale fossero i Fenici in modo
fortuito, accendendo fuochi sulle rive del fiume Belo in Siria e provocando la
fusione per il calore di blocchi di nitrato, dando origine a granuli di
materiale duro e semitrasparente.
Oggi la più anticha testimonianza della
lavorazione del vetro è costituita dal ritrovamento di una barra di vetro blu
del tardo periodo sargonide (XXIII secolo a.C.)
rinvenuta ad Eshnunna, in Mesopotamia. Solo intorno
al XVI - XV secolo a.C. (da questa data esistono fonti scritte), in Mesopotamia
(Iraq) e nel nord della Siria, iniziò la produzione di piccoli vasi e balsamari, realizzati modellando il vetro attorno ad un
nucleo di materiale inerte, argilla e sterco, che era poi rimosso. Tale
procedimento di formazione dal nucleo si diffuse rapidamente e fu adottato per
oltre 1500 anni fino alla scoperta del metodo per soffiatura. Correttamente
Plinio indicava, nella sua storia naturale, le tre componenti fondamentali del
vetro: il natron, una soda naturale; la silice presente nella sabbia, che
conteneva anche il terzo elemento la calce. Si otteneva un vetro verde bluastro
a causa della presenza di impurità di ferro, che solo con un’accurata selezione
della sabbia poteva risultare incolore; ma già in epoca romana erano usati
quali decoloranti il manganese e l’antimonio. Il biossido di manganese ossida i
sali ferrosi dandogli una colorazione giallastra; ma, grazie al suo colore
violetto, risulta complementare del giallo ed otticamente lo annulla rendendolo
incolore. Con ossidi metallici e diverse
temperature si realizzavano varie colorazioni: dal rame il turchese, il blu
chiaro, il verde scuro, il rosso rubino e quello opaco; dal cobalto il verde
intenso; dall’antimonio il bianco, il giallo e l’arancio opachi; dal manganese
il verde giallognolo e quello rossastro; dal ferro il verde bottiglia ed il blu
pallido. Questi primi vasi potevano essere sia in vetro monocromo, decorato con
filamenti colorati, sia in vetro a mosaico. Sempre in quest’epoca è attestata
un'attività vetraria in Egitto, come dimostrato da due vasetti, ora conservati
a Monaco e Londra, con il nome del faraone Tutmosi
III (1490 - 1436 a.C.),
che probabilmente importò, dopo le sue vittoriose guerre in Mesopotamia e
Siria, lavoratori da quelle terre. In Grecia il vetro era chiamato keyanos, come
risulta da documenti micenei, per la produzione di monili e placchette per
l’intarsio dei mobili; un uso principesco di lusso riportato nei testi omerici.
Durante l’età del ferro dal IX secolo una nuova fase produttiva su ampia scala
portò alla ripresa dell’industria vetraria, con la produzione da parte dei
fenici di intarsi di vetro su avorio. Alla metà del VIII secolo a.C.
ricomparvero i contenitori in vetro eseguiti in serie, oltre ad una particolare
produzione di vasi a pareti molto spesse e quasi trasparenti, le cui forme
imitavano quelli in metallo e pietra. Oltre al sistema di formatura dal nucleo
i fenici usarono anche quello della cera persa, in cui il modello di cera era
inglobato in una forma di argilla; una volta sciolta la cera durante la cottura
della creta, lo spazio vuoto era riempito per colatura dal vetro, poi si
liberava il manufatto rompendo ed eliminando la forma, che lo conteneva. Tra
questi si trovano phiàlai,
vasi potori in forma di coppe semplici e lobate, e rhyta, vasi configurati in forma
umana o animale. Questo artigianato, collegato alle vicende dell'impero assiro,
scomparve con la sua caduta (612
a.C.). Tra l’VIII e il VI sec. si inizia la produzione di ciotole semisferiche per
bere, dette da palmo, ottenute per formatura mediante pressatura
(schiacciamento) della levata
(termine indicante la quantità di vetro necessaria, levata dal forno; detta
anche bolo) di vetro su di una forma; tale schiacciatura si ottiene posando la
massa di vetro sulla forma e facendola adagiare, mediante riscaldamento, sulla
stessa. Ma è soprattutto in età ellenistica, a partire dalla metà del sesto
secolo a.C., che i vasi in vetro, prodotti dal nucleo, si diffusero
maggiormente. La produzione mediterranea può suddividersi in tre periodi: dal
550 al 400 a.C.
con le vetrerie di Rodi, 340-200
a.C. nelle Magna Grecia durante il dominio macedone,
150-50 a.C.
in area sirio-palestinese. Ed è proprio dal III secolo che la produzione
ellenistica e quella romana si caratterizzano per la qualità dei vasi prodotti
a mosaico. Il mosaico era ottenuto filando canne di vetro, che affettate
mostravano trasversalmente complessi disegni concentrici. I dischetti ottenuti
venivano affiancati su di una piastra e fusi insieme uno contro l’altro fino a
formare un unico piano, cui poi si dava la forma desiderata, sempre per
pressatura. Una curiosa applicazione del mosaico era quella realizzata in
Egitto dove le canne raffiguravano solo metà di un volto e solo dopo averle
affettate si univano due metà per ottenere un viso completo. Un’altra splendida
decorazione era realizzata applicando disegni in foglia d’oro alla superficie
esterna del vaso, che poi era coperta da un altro strato esterno di vetro; in
questa epoca le due pareti non erano fuse insieme, come fu fatto poi in tarda
epoca romana e rinascimentale, ma restavano relativamente separate in un doppio
strato. Un altro curioso utilizzo del vetro pressato in stampi è quello della
produzione delle phalerae
medaglie con l’effige dei membri della famiglia imperiale, portate dai
legionari di basso rango, al posto delle più preziose d’argento e di bronzo
argentato, durante le parate; esse erano in numero di nove.
A partire dal I secolo d.C. inizia la
produzione di vetri per finestre.
Tuttavia, l'invenzione più
rivoluzionaria della storia del vetro fu l'introduzione della soffiatura nella
seconda metà del I secolo a.C.; documentata da ritrovamenti, avvenuti a
Gerusalemme, di scarti e canne per soffiare. La soffiatura rimane tuttora la
principale tecnica di lavorazione del vetro sia artigianale che industriale.
Essa, originaria dell'area siro - palestinese, unita
all'utilizzo di stampi, consentiva, infatti, di produrre una maggiore quantità
di oggetti in tempi rapidi riducendo notevolmente i costi di realizzazione. Dal
40 d.C. si fabbricano piccole bottiglie quadrangolari e dal 70 altre più grandi
poligonali, la cui altezza è generalmente compresa tra i 10 ed i 40 centimetri. La
tecnica di lavorazione della soffiatura è abbastanza semplice. Quella libera
avviene fondendo a temperature elevate il vetro in grandi crogioli, destinati
ad accogliere la miscela durante il processo di fusione all'interno della
fornace; da questi il vetraio prende con l'estremità della propria canna una
piccola parte, il bolo, allo stato
fluido e leggermente vischioso, stato che si mantiene fino a 500°, poi soffia
nella canna e allargando e stringendo la forma soffiata, anche con l'aiuto di
pinze e semplici strumenti, dà all'oggetto la conformazione desiderata. La
soffiatura dentro matrice è realizzata soffiando la massa di vetro dentro la
forma, che a contatto con essa si raffredda e si distacca; il vasaio poi,
estratto l'oggetto, lo completa con l'orlo e l'applicazione, se prevista, di
anse e piede. Il vetro caldo aderisce quasi istantaneamente a contatto con
l’altro vetro caldo. Le matrici impiegate, potevano essere anche a due o più
valve di terracotta, marmo, metallo e legno. Nelle produzioni ellenistiche e
romane l'ingrediente principale era la sabbia; un tipo di estrema finezza che
consentiva di ottenere del vetro abbastanza puro, si trova in Campania, tra Cuma e Liternum, vicino al fiume
Volturno. Nella composizione del vetro distinguiamo ingredienti primari,
silicati, gli alcali ed i carbonati di calcio e secondari, gli agenti coloranti
ed il vetro rotto. I silicati, che costituivano l'ingrediente base, si
ottenevano principalmente dalla sabbia; poiché questa, raggiunge il punto di
fusione solo ad elevate temperature, erano aggiunti gli alcali, di origine
minerale (soda) o vegetale (soda e potassa), composti di carbonato di sodio,
che consentivano di fondere la miscela a temperature non troppo alte ed inoltre
di mantenere il più possibile plasmabile la massa vetrosa. Infine, i carbonati
di calcio, il terzo ingrediente del vetro, servivano a rendere l'impasto vitreo
insolubile in acqua. Frammenti di vasi o scarti di lavorazione erano aggiunti
sia per una forma di recupero, sia perché permettevano di accelerare la fusione
degli altri ingredienti a temperature meno elevate. Altra tecnica molto
particolare usata per produzioni raffinate, era quella del vetro – cammeo
consistente nel sovrapporre ad uno strato di vetro dal colore intenso,
comunemente blu cobalto, un secondo strato di vetro bianco opaco, che era poi
in parte rimosso a seconda del disegno da realizzare. Risultava un notevole
effetto di contrasto tra il disegno risparmiato in bianco ed il fondo scuro.
Nella tarda età augustea, oltre ai rinomati centri di produzione di Roma, Sidone ed Alessandria, il vetro era lavorato anche in
Spagna e nelle Gallie. Durante i primi due secoli
dell'Impero, i manufatti italici risalivano le grandi arterie fluviali delle Gallie e del Norico, giungendo
nelle vaste pianure dell'Europa centrale ed anche nella penisola iberica e
nelle province africane; arrivando a dominare in Occidente il mercato interno e
quelli provinciali. Tra il II ed III secolo d.C. si determina un'inversione di
tendenza, con la nascita e lo sviluppo dei grandi centri vetrari nelle
province. Tra il IV ed il VII secolo in area proto-bizzantina
sono stati rinvenuti vetri da finestre, sovente scambiati per piccoli piatti,
diffusi anche in Italia, soprattutto per le vetrate delle chiese. Tra la fine
del IV ed il V sec. d.C., con le grandi migrazioni dei popoli germanici, si
assiste ad un complessivo arretramento delle produzioni occidentali rispetto a
quelle orientali. Gli oggetti in vetro sono di qualità sempre più modesta, e
tale situazione di decadimento culminò nel VII secolo, quando la produzione era
rivolta solo ad oggetti d’uso. L'unica eccezione sembra riguardare le produzioni
merovinge, dinastia franca tra il 450 ed il 751, eredi della grande tradizione
renana e quelle della successiva carolingia fino alla frantumazione del loro
impero all’inizio del 900. Il divieto di seppellire i defunti insieme ai loro
averi promulgato nel VII secolo dalla chiesa portò alla scomparsa dei corredi
funerari; inoltre dal IX secolo fu parimenti vietato l’utilizzo dei calici di
vetro, perché poteva accadere che si rompessero disperdendo il prezioso
contenuto. Vetri da finestre erano prodotti prima del 1000 nel monastero
benedettino di San Vincenzo al Volturno ed un frate vitrearius sovrintendeva alle
vetrate nei monasteri del nord Europa. Fino al 1000 si era utilizzate solo la
soda naturale, il natron; da questa data nel nord si inizia ad usare la
potassa, ricavata dalle ceneri delle felci e di altre piante del sottobosco.
RITORNA ALLA HOMEPAGE